Scetavajasse
 ‘O scetavajasse è uno strumento composto da due parti, due aste di legno, delle quali una è iscia e l’altra presente una faccia dentellata con ai lati dei piattini metallici (a volte i piattini possono trovarsi anche sulla faccio opposta alla dentellatura).A volte, durante le rappresentazioni folkloristiche, entramvi i bastoni sono decorati con nastri colorati, mentre alcuni strumenti possono essere arricchiti con dei piccoli intarsi.
‘O scetavajasse è uno strumento composto da due parti, due aste di legno, delle quali una è iscia e l’altra presente una faccia dentellata con ai lati dei piattini metallici (a volte i piattini possono trovarsi anche sulla faccio opposta alla dentellatura).A volte, durante le rappresentazioni folkloristiche, entramvi i bastoni sono decorati con nastri colorati, mentre alcuni strumenti possono essere arricchiti con dei piccoli intarsi.
Il suono viene riprodotto facendo scorrere l’altra asta lungo la faccia dentata dell’altra (appoggiata alla spalla, quasi fosse un violini), producendo il caratteristico strepitio (in napoletano è detto “nfrunfrù”) causato soprattutto dalla vibrazione dei piattini.
Ed è prorio il suono dello strumento che gli ha conferito l’originale nome di Scetavajasse che, letteralmente, deriva dalla composizione di “sceta” (sveglia) e vajasse (serva o domestica, ma anche usato come sinonimo di donna di bassa condizione civile, sguaiata e volgare). Si accompagna generalmente ad altri strumenti come il putipù e le triccheballacche.
In passato, esisteva un secondo tipo di scetavajasse, detto “pandola”, che era costituita da due canne di bambù, una delle quali dentellata, che si infilavano una dentro l’altra per produrre il suono. Ma la fragilità dei materiali con cui lo strumonento era costruito lo ha condannato ad una graduale scomparsa.


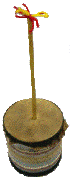 La caccavella (o Putipù) era costituito originariamente da una pentol di coccio abbastanza ampia, sulla quale veniva distesta una pelle di ovino, fissata ai bordi con dello spago. Al centro, veniva poi praticato un piccolo buco attraverso il quale si infilatava un’asta di legno che, dopo essere stata inumidita, produceva grazie ad un movimento verticale il tipico suono, simile al contrabbasso (evocato anche dal nome putipù), dove la pentola descritta in precedenza faceva da cassa di risonanza.
La caccavella (o Putipù) era costituito originariamente da una pentol di coccio abbastanza ampia, sulla quale veniva distesta una pelle di ovino, fissata ai bordi con dello spago. Al centro, veniva poi praticato un piccolo buco attraverso il quale si infilatava un’asta di legno che, dopo essere stata inumidita, produceva grazie ad un movimento verticale il tipico suono, simile al contrabbasso (evocato anche dal nome putipù), dove la pentola descritta in precedenza faceva da cassa di risonanza.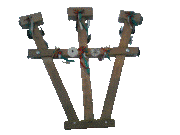 ‘O triccheballacche è un tipico strumento molto diffuso in tutta l’Italia centro-meridionale che, come molti altri, viene suonato a percussione o a scuotimento.
‘O triccheballacche è un tipico strumento molto diffuso in tutta l’Italia centro-meridionale che, come molti altri, viene suonato a percussione o a scuotimento. Il mandolino è lo strumento principe della musica napoletana, simile al liuto e alla chitarra.
Il mandolino è lo strumento principe della musica napoletana, simile al liuto e alla chitarra.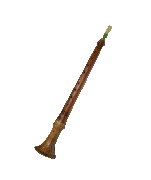 La ciaramella è uno strumento a fiato, simile al piffero, spesso inserito nelle cornamuse per relalizzare la melodia.
La ciaramella è uno strumento a fiato, simile al piffero, spesso inserito nelle cornamuse per relalizzare la melodia. La zampogna è uno strumento a fiato, tipico del sud italia, formato da 4 o 5 canne di legno e da una sacca in cui viene accumulata l’aria soffiata dal suonatore.
La zampogna è uno strumento a fiato, tipico del sud italia, formato da 4 o 5 canne di legno e da una sacca in cui viene accumulata l’aria soffiata dal suonatore. Il calascione, versione napoletana del colascione, è uno strumento risalente al XVII secolo, caratterizzada da un manico lunghissimo (tra 1 e due metri) a fronte di una cassa molto piccola. Detto anche “tiorba a taccone”, il suo nome, pur ispirandosi allo strumento arabo “tambur”, deriva dal greco “galischan” (piccola cesta).
Il calascione, versione napoletana del colascione, è uno strumento risalente al XVII secolo, caratterizzada da un manico lunghissimo (tra 1 e due metri) a fronte di una cassa molto piccola. Detto anche “tiorba a taccone”, il suo nome, pur ispirandosi allo strumento arabo “tambur”, deriva dal greco “galischan” (piccola cesta). Il Sisco (detto anche piffero o zufolo) è un piccolo flauto dolce costituito solitamente da materiale povero, come una canna di bambù (anche se ve ne sono esemplari in legno, terracotta, osso e perfino avorio), con il quale si producono suoni molto acuti.
Il Sisco (detto anche piffero o zufolo) è un piccolo flauto dolce costituito solitamente da materiale povero, come una canna di bambù (anche se ve ne sono esemplari in legno, terracotta, osso e perfino avorio), con il quale si producono suoni molto acuti. La tromma (o scacciapensieri) è uno stumento idiofono a bocca, di origine asiatica, diffuso in quasi tutto il mondo.
La tromma (o scacciapensieri) è uno stumento idiofono a bocca, di origine asiatica, diffuso in quasi tutto il mondo.