Duomo di Napoli – Cappella del Tesoro di San Gennaro
Storia e descrizione
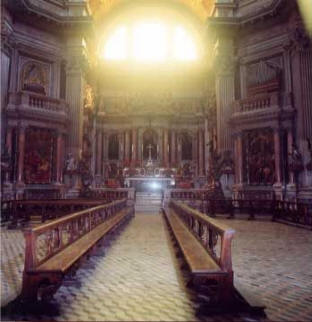 La
Lacappella non custodisce soltanto le reliquie ed il sangue di San Gennaro, ma è
sicuramente anche un gioiello di arte e architettura di livello mondiale che
racchiude marmi, affreschi, dipinti dei migliori artisti dell’epoca e del
movimento barocco napoletano. Fu progettata dal frate Francesco Grimaldi e la
sua costruzione, ultimata nel 1646, avvenne sulle cappelle delle famiglie
Filomarino, Capace e Cavaselice. Dopo la morte dell’architetto, l’opera fu
portata a termine Ceccardo Bernucci e Giovan Giacomo di Conforto.
In origine, come detto, il Tesoro del Santo era custodito nella torre situata
alla sinistra della facciata alla quale si accedeva attraverso un passaggio
stretto e angusto. L’occasione per una nuova costruzione arriva nel 1527. In
questo periodo la città di Napoli stava vivendo un periodo difficile, martoriata
dalla peste e dalla guerra tra Spagna e Francia. Così, il 13 gennaio,
nell’anniversario del trasferimento delle ossa del santo da Montevergine a
Napoli, il popolo decide di affidarsi al patrono San Gennaro, formulando il voto
di erigere una nuova Cappella.
Nel 1601 fu fondata la Deputazione della Real Cappella del Tesoro, alla quale
venne affidato l’incarico di organizzare la costruzione e la fondazione della
nuova struttura. Inaugurazione che avvenne il 16 dicembre 1646, giorno in cui le
reliquie furono trasferite nella nuova sede.
Le Sacre Reliquie
 Le
Lereliquie hanno avuto una storia abbastanza travagliata prima di trovare la
collocazione attuale: prima Marciano, poi Benevento, fino a raggiungere il
Monastero di Montevergine. Qui, nel 1480 furono ritrovate e nel 1497 portate
nella cattedrale e poste nell’ipogeo della cattedrale, detto Succorpo, dove
ancora oggi sono conservate le ampolle col sangue.
Oltre alle ossa, custodite nel Succorpo, gli altri resti del Santo sono
custoditi nella Cappella del Tesoro in due artistici reliquiari. Il busto,
costruito a grandezza naturale, rappresenta un capolavoro dell’oreficeria
trecentesca; poggia su una base realizzata in argento di forma ellittica,
risalente al 1609 e voluta da Giovanni Tommaso Vespolo. Davanti è rappresentata
la Decollazione del Santo, sul retro, invece, il suo Martirio sullo sfondo di
quello che dovrebbe essere l’anfiteatro di Pozzuoli. Il busto vero e proprio,
invece, è stato modellato da argentieri francesi (Etienne Godefroyd, Guillame de
Verdelay e Millet d’Auxerre) su commissione di Carlo II d’Angiò ed è cavo per
poter contenere le ossa del capo del Santo. L’opera fu completata nel 1305 e si
ispira a quella custodita presso la Solfatara di Pozzuoli: San Gennaro è
rappresentato con un volto giovanile, con i capelli che si raccolgono sotto ad
una calotta di argento fissata con viti, posta per proteggere le ossa del
cranio. Il busto veste con la casula a collo alto, decorata da rosette,
ornamenti smaltati, stemmi angioini e pietre preziose.
Il sangue del Santo, invece, è custodito in due ampolle di vetro di forma
diversa, rinchiuse in una doppia teca. Quella interna, probabilmente di epoca
angioina, serve per fissare le ampolle con del mastice scuro. L’altra, più
recente, risale al Seicento e contiene il reliquiario più antico delle ampolle.
La teca poggia su un reliquiario con base in ebano, ricoperta da lamine
d’argento con lo stemma del Cardinale Ascanio Filomarino risalente al 1643,
composto da una parte antica, che riproduce una struttura architettonica gotica,
e una più moderna composta da un florilegio circolare che lo chiude in alto.
Nella prima parte possiamo trovare colonnine, pilastri guglie e un arco in cui è
custodita una piccola statua di San Gennaro. Successivamente, alla base sono
stati aggiunti nel XVII secolo una raggiera con due angeli e un grande smeraldo,
circondata da una corona di fiori che rappresenta il modo in cui i partecipanti
alla processione di San Gennaro si ornavano il capo.
Descrizione architettonica e arredi
La cappella è molto grande ed è un chiaro e rappresentativo esempio di
architettura barocca, con pianta centrale a croce greca, con cupola a doppia
calotta formata da due cupole con intercapedine.
La facciata occupa tre campate e l’ingresso ha fronte a triplice arcata,
sormontato da una trabeazione di Francesco Banelli, realizzata nel 1626 su cui è
incisa in latino la dedica al santo :”A San Gennaro, al cittadino salvatore
della patria, Napoli, salvata dalla fame, dalla guerra, dalla peste e dal fuoco
del Vesuvio per virtù del suo sangue prodigioso, consacra”.
All’ingresso troviamo il maestoso cancello d’ottone, tra due colonne di marmo
nero venato di bianco e verde, i cui capitelli furono scolpiti da Donato Vanelli
e Rinaldo Mele. Il cancello fu progettato tra il 1628 e il 1630 da Cosimo
Fanzago e realizzato in parte da Orazio Scoppa e Biagio Monte. Il suo
completamento, però, si deve all’ottonaro Gennaro Monte che realizzò anche il
busto bifronte di San Gennaro posto al di sopra. Nelle due edicole laterali,
sono conservate le statue di San Pietro e Giuliano Finelli.
All’interno della cappella possiamo trovare sette altari, quarantadue colonne di
broccatello e diciannove statue in bronzo raffiguranti santi patroni. Il
pavimento fu progettato da Cosimo Fanzago e presenta tasselli di vario
materiale e colore, con marmo bianco, grigio e broccatello.
L’altare maggiore fu progettato da Francesco Solimena: è realizzato in porfido
con cornici, fregio e modanature in argento e rame indorato. I puttini di
argento ai suoi lati sono opera di Nicola de Turris. Nella parte frontale, il
paliotto d’argento, un capolavoro dell’argenteria napoletana del XVII secolo,
realizzato dall’orafo Giandomenico Vinaccia nel 1698 su disegno di Dionisio
Lazzari. Su di esso è raffigurato l’arrivo delle reliquie del Santo a Napoli nel
1497: l’Arcivesovo Alessandro Carafa si trova a cavallo e regge il cofanetto
delle reliquie con San Gennaro che, dall’alto, protegge la città, simbolicamente
rappresentata dalla sirena Partenope e dal fiume Sebeto e, sulla sinistra, dal
Vesuvio in eruzione. La peste, la fame e la guerra fuggono davanti alle reliquie
in arrivo, mentre l’eresia è schiacciata dal cavallo dell’arcivescovo.
Nella parete dietro l’altare, troviamo una nicchia con cassaforte e sportelli
dorati, donati dal vicerè Pietro d’Aragona per volere di re Carlo II nel 1603,
in cui sono custoditi il busto in argento dorato e la reliquia del sangue.
Sempre dietro l’altare, in alto, è posta la statua in bronzo di San Gennaro,
realizzata da Giuliano Finelli che nel 1654 sostituì quella di Tommaso Montani,
sistemata in cima alla guglia di Piazzetta Riario Sforza.
La balaustra del presbiterio venne realizzata da Giuliano Vanelli nel 1618 su
disegno di Francesco Grimaldi.
I paliotti degli altri altari risalgono all’Ottocento, quelli laterali sono
opera di Giuseppe e Gennaro del Giudice, mentre quelli degli altari ai quattro
angoli di Luigi Magliulo. Il loro rivestimento argentato risale all’Ottocento,
donato da Francesco II per volere del padre.
All’interno della Cappella si trovano numerose statue in bronzo o argento, per
un totale di 51, a partire da quella di San Tommaso d’Aquino del 1605, fino ad
arrivare a quella di Santa Rita del 1928. Gli altri santi raffigurati sono San
Tommaso, Sant’Agnello, San Severo, Sant’Agrippino, Sant’Eufebio, Sant’Andrea
Avellino, San Giacomo della Marca, Santa Patrizia, San Francesco di Paola, San
Domenico e San Biagio (poi trasformato in San Nicola), Santa Teresa d’Avila e
Sant’Antonio, San Filippo Neri, San Gaetano, Sant’Aspreno.
architettura barocca, con pianta centrale a croce greca, con cupola a doppia
calotta formata da due cupole con intercapedine.
La facciata occupa tre campate e l’ingresso ha fronte a triplice arcata,
sormontato da una trabeazione di Francesco Banelli, realizzata nel 1626 su cui è
incisa in latino la dedica al santo :”A San Gennaro, al cittadino salvatore
della patria, Napoli, salvata dalla fame, dalla guerra, dalla peste e dal fuoco
del Vesuvio per virtù del suo sangue prodigioso, consacra”.
All’ingresso troviamo il maestoso cancello d’ottone, tra due colonne di marmo
nero venato di bianco e verde, i cui capitelli furono scolpiti da Donato Vanelli
e Rinaldo Mele. Il cancello fu progettato tra il 1628 e il 1630 da Cosimo
Fanzago e realizzato in parte da Orazio Scoppa e Biagio Monte. Il suo
completamento, però, si deve all’ottonaro Gennaro Monte che realizzò anche il
busto bifronte di San Gennaro posto al di sopra. Nelle due edicole laterali,
sono conservate le statue di San Pietro e Giuliano Finelli.
All’interno della cappella possiamo trovare sette altari, quarantadue colonne di
broccatello e diciannove statue in bronzo raffiguranti santi patroni. Il
pavimento fu progettato da Cosimo Fanzago e presenta tasselli di vario
materiale e colore, con marmo bianco, grigio e broccatello.
L’altare maggiore fu progettato da Francesco Solimena: è realizzato in porfido
con cornici, fregio e modanature in argento e rame indorato. I puttini di
argento ai suoi lati sono opera di Nicola de Turris. Nella parte frontale, il
paliotto d’argento, un capolavoro dell’argenteria napoletana del XVII secolo,
realizzato dall’orafo Giandomenico Vinaccia nel 1698 su disegno di Dionisio
Lazzari. Su di esso è raffigurato l’arrivo delle reliquie del Santo a Napoli nel
1497: l’Arcivesovo Alessandro Carafa si trova a cavallo e regge il cofanetto
delle reliquie con San Gennaro che, dall’alto, protegge la città, simbolicamente
rappresentata dalla sirena Partenope e dal fiume Sebeto e, sulla sinistra, dal
Vesuvio in eruzione. La peste, la fame e la guerra fuggono davanti alle reliquie
in arrivo, mentre l’eresia è schiacciata dal cavallo dell’arcivescovo.
Nella parete dietro l’altare, troviamo una nicchia con cassaforte e sportelli
dorati, donati dal vicerè Pietro d’Aragona per volere di re Carlo II nel 1603,
in cui sono custoditi il busto in argento dorato e la reliquia del sangue.
Sempre dietro l’altare, in alto, è posta la statua in bronzo di San Gennaro,
realizzata da Giuliano Finelli che nel 1654 sostituì quella di Tommaso Montani,
sistemata in cima alla guglia di Piazzetta Riario Sforza.
La balaustra del presbiterio venne realizzata da Giuliano Vanelli nel 1618 su
disegno di Francesco Grimaldi.
I paliotti degli altri altari risalgono all’Ottocento, quelli laterali sono
opera di Giuseppe e Gennaro del Giudice, mentre quelli degli altari ai quattro
angoli di Luigi Magliulo. Il loro rivestimento argentato risale all’Ottocento,
donato da Francesco II per volere del padre.
All’interno della Cappella si trovano numerose statue in bronzo o argento, per
un totale di 51, a partire da quella di San Tommaso d’Aquino del 1605, fino ad
arrivare a quella di Santa Rita del 1928. Gli altri santi raffigurati sono San
Tommaso, Sant’Agnello, San Severo, Sant’Agrippino, Sant’Eufebio, Sant’Andrea
Avellino, San Giacomo della Marca, Santa Patrizia, San Francesco di Paola, San
Domenico e San Biagio (poi trasformato in San Nicola), Santa Teresa d’Avila e
Sant’Antonio, San Filippo Neri, San Gaetano, Sant’Aspreno.
Gli affreschi
Tutti gli affreschi alle pareti furono eseguiti dal bolognese Domenico Zampieri,
detto il Dominichino, che, a causa della morte improvvisa non riuscì a decorare
anche la cupola. Sopra il cancello d’ingresso è raffigurata la Processione con
le reliquie del Santo, sull’altare destro troviamo San Gennaro condotto al
martirio, su quello destro San Gennaro che libera Napoli dai Saraceni, mentre
nella volta sopra l’altare maggiore è dipinta una serie di scene della martirio
del Santo.
Della decorazione della cupola si occupò Giovanni Lanfranco che nel 1643 dipinse
il Paradiso, costituito da una serie di figure in cerchi concentrici verso
l’altro. Si possono distinguere tre gruppi: San Gennaro in preghiera davanti al
Cristo, la Vergine che implora protezione per Napoli e Dio al centro come polo
d’attrazione per i santi in preghiera.
Sull’altare di destra è conservato un dipinto di Giuseppe Ribera, detto lo
Spagnoletto, realizzato a olio su rame nel 1647 e raffigurante San Gennaro che
esce illeso dalla fornace di Nola. Sull’altare di sinistra, invece, il
Dominichino dipinse la Decollazione di San Gennaro. Lo stesso artista, inoltre,
realizzò i dipinti nei quattro altari agli angoli: Infermi guariti con l’olio
della lampada, la Resurrezione di un morto, gli Infermi al sepolcro e l’Ossessa
liberata (rimasta incompiuta). Questi dipinti furono completati con delle
cornici in bronzo dorato e lapislazzuli, opera di Onofrio d’Alessio, al quale fu
affidata anche la realizzazione dei cancelli delle cappelle.
Nella cappella alla sinistra del vestibolo, la volta fu decorata a stucchi da
Andrea Falcone e Giambattista Adamo. Gli affreschi, invece, iniziati da Luca
Giordano, furono completati da Giacomo Farelli. Sull’altare Massimo Stanzione
dipinse su rame l’Ossessa liberata, opera che avrebbe dovuto sostituire quella
incompiuta del Domenichino.
Nella sala capitolare dei prelati della cappella è custodito un San Gennaro
opera di Francesco soli mena risalente al 10702, ma anche due cimeli bellici:
una bandiera strappata ai turchi nella battaglia di Belgrado nel 1717 e donata
al Tesoro da Carlo VI e un’altra bandiera presa da Carlo di Borbone agli
austriaci nella battaglia di Velletri del 1744.
detto il Dominichino, che, a causa della morte improvvisa non riuscì a decorare
anche la cupola. Sopra il cancello d’ingresso è raffigurata la Processione con
le reliquie del Santo, sull’altare destro troviamo San Gennaro condotto al
martirio, su quello destro San Gennaro che libera Napoli dai Saraceni, mentre
nella volta sopra l’altare maggiore è dipinta una serie di scene della martirio
del Santo.
Della decorazione della cupola si occupò Giovanni Lanfranco che nel 1643 dipinse
il Paradiso, costituito da una serie di figure in cerchi concentrici verso
l’altro. Si possono distinguere tre gruppi: San Gennaro in preghiera davanti al
Cristo, la Vergine che implora protezione per Napoli e Dio al centro come polo
d’attrazione per i santi in preghiera.
Sull’altare di destra è conservato un dipinto di Giuseppe Ribera, detto lo
Spagnoletto, realizzato a olio su rame nel 1647 e raffigurante San Gennaro che
esce illeso dalla fornace di Nola. Sull’altare di sinistra, invece, il
Dominichino dipinse la Decollazione di San Gennaro. Lo stesso artista, inoltre,
realizzò i dipinti nei quattro altari agli angoli: Infermi guariti con l’olio
della lampada, la Resurrezione di un morto, gli Infermi al sepolcro e l’Ossessa
liberata (rimasta incompiuta). Questi dipinti furono completati con delle
cornici in bronzo dorato e lapislazzuli, opera di Onofrio d’Alessio, al quale fu
affidata anche la realizzazione dei cancelli delle cappelle.
Nella cappella alla sinistra del vestibolo, la volta fu decorata a stucchi da
Andrea Falcone e Giambattista Adamo. Gli affreschi, invece, iniziati da Luca
Giordano, furono completati da Giacomo Farelli. Sull’altare Massimo Stanzione
dipinse su rame l’Ossessa liberata, opera che avrebbe dovuto sostituire quella
incompiuta del Domenichino.
Nella sala capitolare dei prelati della cappella è custodito un San Gennaro
opera di Francesco soli mena risalente al 10702, ma anche due cimeli bellici:
una bandiera strappata ai turchi nella battaglia di Belgrado nel 1717 e donata
al Tesoro da Carlo VI e un’altra bandiera presa da Carlo di Borbone agli
austriaci nella battaglia di Velletri del 1744.
| << Navata destra | Transetto >> |


Dove si trova esattamente a Napoli…si trova a Vomero?
No. Il duomo si trova nel centro storico, in Via Duomo
vorrei visitare questa bellissima cappella-
Vorrei sapere esattamente l’indirizzo della basilica di San Gennaro,vorrei scrivergli una lettera,dato che vivo in canada..grazie tanto Caterina